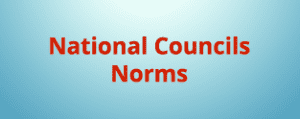Sua Ecc. Mons. Beniamino Depalma C.M., Arcivescovo
Sua Ecc. Mons. Beniamino Depalma C.M., Arcivescovo
- Attualizzare il carisma:
San Vincenzo non era un ideologo della povertà
La frontiera dell’immigrazione, “nuova” oggi per dimensione e consistenza, trova noi vincenziani in prima linea nella comprensione e nell’accoglienza di un fenomeno le cui dimensioni sono crescenti. Per noi non si tratta solo d
i esprimere la logica del Vangelo sull’accoglienza: siamo chiamati anche ad attualizzare il carisma del nostro Fondatore che in queste “periferie esistenziali”, richiamando il pensiero di Papa Francesco, aveva già messo piede al suo tempo. Vincenzo de’ Paoli, infatti, durante la “Guerra dei trent’anni” si trovò a far fronte ad una nuova povertà per l’epoca, che si aggiunse all’accoglienza degli orfani e dei diseredati, anche lui si fece carico dell’accoglienza dei flussi migratori che cercavano rifugio e assistenza dalle rastrellate belliche. Pertanto, i vincenziani, sono chiamati oggi a farsi prossimi in questa nuova povertà, senza escludere le altre. Si tratta di prendere sul serio che il monito di Gesù “ero forestiero” è l’incarnazione del vangelo oggi, individuando nelle opere di misericordia, la forma contemplativa in azione del nostro essere discepoli di Cristo. Tale impegno per noi non si caratterizza in una analisi sociologica sulla migrazione; San Vincenzo non era un “ideologo della povertà”: a lui interessava la persona dei poveri. Per questo motivo, come suoi figli, siamo chiamati a garantire – senza paura di essere anche impopolari se è necessario – la sicurezza delle persone prima che la sicurezza culturale e sociale delle Nazioni. Questa nuova frontiera di apostolato ci chiede l’urgenza di accogliere le persone. Ci troviamo in un momento storico in cui il razzismo e la xenofobia molte volte sono mascherati da sottili ragionamenti sulla precuppazione di non perdere i “nostri valori cristiani”. Non di rado per differire l’accoglienza si vorrebbe far leva su di un presunto conflitto di religioni. Così affermando si dimentica che il cristianesimo – come ci ha ricordato Benedetto XVI nell’introduzione dell’ enciclica Deus Caritas est – non è una cultura e neanche una religione, ma l’incontro con la persona di Gesù Cristo che ci insegna uno stile e un metodo di accoglienza. Come non pensare agli incontri del Maestro con i migranti della Decapoli… L’incontro, ad esempio, tra Gesù e la donna cananea ci dimostra che l’incontro con le persone va oltre i limiti geografici e culturali.
Ci aiuta nella riflessione l’insegnamento del Concilio Vaticano II che nella Gaudium et spes, richiamando il valore della condivisione, permette di cogliere un metodo efficace perché l’accoglienza sia efficace e costante. Ossia, il “lavorare in rete” con le istituzioni locali, le diocesi, le parrocchie, le associazioni di volontariato. Tutti tesi e protesi verso l’unico fine: evangelizzare l’umano attraverso l’accoglienza sullo stile di Gesù e umanizzare il Vangelo, attualizzarlo nelle nuove frontiere di apostolato secondo l’insegnamento di San Vincenzo.
Questo dovere di accoglienza che – come ho affermato – ha un carattere prettamente pastorale non può dimenticare la dimensione dello studio e della riflessione teologica che offrono una spinta e richiamano la motivazione dell’agire concreto.
Mi accingo, pertanto, a offrire qualche traccia di riflessione.
- Con il Vangelo stretto tra le mani
Siamo o no di fronte alla più grande migrazione di esseri umani della storia? È difficile dirlo. La storia dell’umanità è in realtà una storia di migrazioni continue. E la storia dell’umanità è anche la storia della continua difficoltà a gestire e trarre il bene da migrazioni e contaminazioni. Ciò che viviamo oggi non è una novità. Non siamo i primi e non saremo gli ultimi. E ciò che sta accadendo, nel bene e nel male, lo abbiamo già visto sui libri di storia. Anzi, con tratti ancora più drammatici.
La peculiarità dell’oggi è che le migrazioni cadono in una fase di pessimismo globale, di riduzione delle aspettative di benessere dell’Occidente e di lentissima realizzazione delle promesse che aveva fatto la globalizzazione. Dopo la caduta del muro di Berlino pensavamo entusiasticamente ad un nuovo ordine mondiale che avrebbe ridotto le disuguaglianze e distruibuito le risorse nella pace. È invece iniziata una transizione caotica, contraddittoria e violenta.
Di fronte a tutto ciò ci troviamo con una classe dirigente nazionale, europea e globale impreparata, culturalmente discutibile e soprattutto spaventata dal crollo del consenso. Le ragioni dei governanti si sono mischiate alle paure razionali e irrazionali del popolo creando quella miscela esplosiva di populismo, demagogia e razzismo che anima oggi il dibattito nei Parlamenti, nelle piazze reali e in quelle virtuali.
Contemporaneamente, la perdita delle radici da parte dei nostri Paesi occidentali, perdita a volte scientificamente causata, ci fa sentire più fragili e deboli di fronte a sbarchi e ingressi in Italia. E la risposta diventa il rifiuto. La politica rinuncia a governare con raziocinio e asseconda queste dinamiche, mentre dal punto di vista delle politiche locali si fa poco: poca integrazione, poche politiche demografiche, poca giustizia sociale per italiani e stranieri, poco lavoro. È chiaro che ci sentiamo ogni giorno sulla bocca di un vulcano che sta per esplodere, per quanto alcune evidenze statistiche ci impongano maggiore serenità: oggi senza i lavoratori stranieri molti anziani non avrebbero la pensione, domani senza famiglie di migranti chiuderebbero scuole a tutta forza per assenza di bambini.
La Chiesa ha scelto la parte del Vangelo e del buon senso, per fortuna, anche se non mancano spinte e paure regressive. Vangelo e buon senso che hanno voce proprio nel Papa, che predica misericordia e accoglienza ma non dimentica mai di dire ai governanti che i processi vanno gestiti e che tale ondata non può essere scaricata incoscientemente sui cittadini e sulle comunità.
È quindi un’enorme sfida per noi tutti: avere il Vangelo stretto tra le mani senza trasformarlo in utopia buonista, ma vivendolo come radicalità che si incarna.
- Da Narciso ad Abramo:
dall’autoreferenzialità che chiude, alla relazione che apre
Nel nostro contesto culturale, dobbiamo riconoscerlo, “Narciso” è diventato l’ “ospite” per eccellenza comune delle nostre interiori abitazioni, abbiamo ben poco da riservare alla relazione umana, fatta di legami di attesa, dell’ascolto umile di una parola che ridoni vicinanza: siamo nell’epoca dei “selfie”. Ci può aiutare una rilettura dei miti antichi nella rilettura del nostro presente culturale, così segnato da profonde ambiguità e mancate relazioni sebbene, in fondo in fondo, anche desiderate. Pensiamo al mito di Orfeo che non esita a scendere negli inferi, regione buia della non conoscenza e dell’oblio, per riannodare un legame d’amore indissolubile. Tuttavia, anche lui viene preso dalla mancanza di speranza, anche lui si ritrova solo con il suo silenzio senza più né domande né risposte. Il voltarsi indietro, alla ricerca del viso amato, è la tipica ricerca di sicurezza e di ospitalità, ma essa deve riconoscere prima di tutto che il futuro e la ricerca dell’altro si sposa con l’incertezza, altrimenti di quale ricerca si dovrebbe parlare? Il volto degli altri, ci direbbe Levinas, ci sta davanti come un’oggettualità incomprensibile eppure domestica e solo accettandolo si può predisporre il nostro essere a cercare. Quaesivi et non inveni: ho cercato, spiega Orfeo, ma non ho trovato. E allora un atteggiamento consapevole può essere quello di Telemaco che si muove alla ricerca del padre, Odisseo, di cui coltiva solo fantasmi educativi e ne conserva il feroce desiderio. Telemaco, forse più di altri miti, può farci capire una delle caratteristiche del nostro tempo, il tempo in cui i figli cercano i padri; si mettono sulle tracce di un’immagine; percorrono i mari della confusione. Anche Ascanio (Iulo), il figlio di Enea, porgendo le mani al padre, che intanto si è caricato il peso di un altro padre, fondatore della sua stirpe, nell’impazzito dolore di una città in fiamme, lo segue fiducioso, pur non avvistando sentieri calpestabili, nel fumo denso delle alte fiamme. Il ragazzo vedendo correre il padre, corre con lui verso la salvezza. Ecco un’altra stupenda immagine del nostro tempo: una corsa veloce e cooperativa verso un traguardo ignorato, ma presente. Per ultimo ancora ci può illuminare il mite giovane figlio dell’inquieto Dedalo, Icaro, che, inconsapevole erede della follia del labirinto, luogo dell’inestricabile enigma di una ricerca fine a se stessa, accetta di volare. Si fa cioè interprete, come tanti giovani oggi, di un orizzonte azzurro di senso e pur non avendo strumenti, generosamente si lancia verso di essi.
A partire dall’evocazione di questi miti dell’antichità vorrei sottolineare come la ricerca dell’altro è qualcosa che, seppur in maniera difficile, fa parte del nostro DNA umano. Ma come possiamo passare da una dimensione autoreferenziale della ricerca dell’altro, a una ospitalità consapevole e generosa? Abbiamo bisogno di strumenti adeguati, perché senza ali ben salde, che sostengano il peso della fatica, rischiamo di schiantarci contro l’altro, piuttosto che crescere con l’altro. Bisogna accettare la sfida di uscire da se stessi e dalle proprie pretese per cercare l’altro nella verità e per trovarlo veramente, I Vangeli sono pieni di gente che cerca. Chi può dimenticare la fretta di Maria verso la casa di Elisabetta, il desiderio del padrone del podere che scava per far emergere il tesoro, la notte in cui Gesù si fa raggiungere dalla sete di sapere come si può rinascere di Nicodemo, l’arrampicarsi veloce di Zaccheo sull’albero, la corsa del centurione per chiedere inusitatamente la vita di sua figlia, la corsa di Giovanni e di Pietro verso il sepolcro dove ancora credono che giaccia il corpo del loro maestro.
Questa ricerca, dunque, chiede un’ “uscita”, come ci sta ricordando Papa Francesco in numerosi discorsi. Mi pare, pertanto, che sia necessario ritornare alla figura di Abramo, come paradigma fondamentale dell’ospitalità. Abramo accoglie i tre uomini alle Querce di Mamre (Gn 18,1-15), li incontra fuori dalla sua tenda, esce dallo spazio protetto, rilegge la sua storia – fatta anche di fallimenti e infertilità – a partire da quell’incontro. Differentemente da Narciso, non ha un suo volto da contemplare, ma si fa scrutatore attento del volto di quei tre sconosciuti, cerca di capire, di riconoscerli. Rilegge la sua storia passata a partire da quella novità d’incontro. Si prende cura della situazione di oggettivo bisogno di quei tre sconosciuti, li nutre e ne riceve una promessa di futuro attraverso la previsione della nascita di Isacco. Dal dare ospitalità ne riceve fecondità: attraverso il dono del figlio, egli non contemplerà più narcisisticamente il suo volto, ma nel “sorriso” del figlio contemplerà il suo futuro di gioia feconda (cfr. Genesi 22,17). Da quell’ospitalità inizia per lui un viaggio esistenziale; un esodo da se stesso all’altro.
- Ospitare: abitare gli spazi come viaggiatori
- Baumann, descrivendo l’affollato deserto che distingue le nostre comunità, sviluppa una profonda analogia tra le due figure metaforiche del turista e del vagabondo e la nostra itineranza negli spazi anonimi delle città[1]. Egli svolge un acuto ragionamento che ci fa comprendere bene quali siano oggi gli spazi affidati all’educazione e gli spazi che invece educano di per sé. Il turista è mosso solo dalla sua curiosità, vive gli spazi attraverso le sue esigenze, non è coinvolto dalla vita ordinaria di quegli spazi e anche se talvolta lo è, il suo ruolo è quello di un uomo che consuma un piacere esotico. Dall’altro lato il vagabondo è come un nomade, che non lascia traccia, i suoi traguardi sono costantemente temporanei. Entrambi non hanno interesse reale per i luoghi che attraversano e questo per noi vuol dire che essi non stringono un reale legame con essi. C’è un’ulteriore figura a cui dovremmo però prestare attenzione: è quella del viaggiatore. Il viaggiatore è colui che si fa coinvolgere; il viaggio ha come scopo l’esprimere il significato della vita. Abramo si mette in viaggio per realizzare fisicamente un luogo di accoglienza e lo stesso termine terra promessa ci rimanda alla costruzione di punti di ancoraggio, che aiutino gli altri a rendere decifrabili gli elementi che fanno di uno spazio un’abitazione. La tenda tesa del tessitore è uno dei luoghi simbolo dell’ospitalità: la si può arrotolare e portare con sé, come l’errante pastore leopardiano, che cerca il senso delle cose nello specchio pallido e muto della luna (altro luogo simbolico dell’oltre); la si può piantare e sceglierla come spazio del disvelamento di una profezia di fecondità; infine può essere gettata via, lontano, da un vento impetuoso e allora riserva lacrime inconsolabili a chi non riesce ad interpretare i perché drammatici dell’esistenza umana. Abitando un luogo, lo straniero non ci sembrerà mai una minaccia. Vivendo, invece, un luogo come non-nostro, gli stranieri saranno percepiti come nemici, tra cui ci sentiamo persi. Ecco perché i nostri luoghi non sono più accoglienti, perché essi non sono più abitati, sono solo attraversati e si caratterizzano come luoghi di trincea, di fronti avversi, di spazi separati, di piazze sorvegliate. Notiamo quotidianamente che lo spazio per l’accoglienza, oggi, è posto nei confini della scuola, delle palestre, degli oratori ma ha perso, per lo più, i collegamenti con la vita ordinaria della comunità. Il confinamento suona come un’intollerabile separazione, come un carcere di cristallo, che c’è ma si nasconde nell’ordinarietà della vita consumata. Si va nei luoghi citati perché lì viene prescritto qualcosa da fare; c’è un programma da seguire; c’è qualcuno da ascoltare. Non si va mai in questi luoghi perché è lì che si produce un pensiero, che si elaborano idee, in cui, gradualmente ma perennemente, si coltiva (coltura-cultura) un germoglio di novità. Ci sono poi spazi che solo esteticamente sembrano accoglienti. Si pensi ai Centri commerciali: quanti giovani mi dicono che questi sono diventati ormai un’abitudine domenicale irrinunciabile. Anche Gesù Cristo ha attraversato luoghi aridi di in accoglienza ed ha cercato di farli fiorire: i deserti delle tentazioni del potere, gli orti con ulivi centenari, che di notte hanno ascoltato i suoi lamenti di sangue, le stalle della nascita di inattesi piccoli splendori, la case delle feste e della gioia, i templi dello sperpero e della bestemmia e finanche le piazze e le periferie teatro di lapidazioni e crocifissioni usate, allora come oggi, per educare a comportamenti ritenuti civili. L’accoglienza, invece è altra cosa: si carica del difficile compito di ricostruire città che abbiano il coraggio non di gloriarsi delle loro settantasette meraviglie ma si aprano alla meraviglia più grande: il volto dell’Altro da ospitare.
- Accogliere: lasciarsi visitare dallo straniero
Ritornando al racconto delle querce di Mamre, vorrei sottolineare ancora l’importanza della visita dello straniero, che in modo particolare riguarda le nostre città multietniche. Come ci ha ricordato il Cardinale Sepe: “La nostra comunità cattolica, insieme ai fratelli cristiani delle diverse denominazioni e alle altre religioni di antica e recente presenza, mentre offrono l’immagine di una città multietnica e multireligiosa esprimono insieme la volontà di fare di Napoli una città accogliente, scegliendo la via del dialogo rispettoso e pacifico come metodo dello stare insieme, senza nulla togliere alla specificità e alla identità di ciascuno”[2].
Se incontrare l’altro è uno dei paradigmi più significativi dell’ospitalità, non possiamo non riflettere sul fatto che l’incontro prende spesso la configurazione di una visita. L’uomo è fatto per incontrare l’altro, perché questo è l’unico modo che ha per riconoscersi; per questo ogni relazione veramente accogliente è sempre un’attesa dell’altro e diventa così un momento privilegiato per visitare l’altro da sé, ma anche se stessi attraverso gli altri. Non c’è possibilità di ospitalità senza che vi sia incontro di vite, di storie, di culture, ma anche, più semplicemente, di parole, di gesti, di sentimenti ed emozioni che veicolino non solo contenuti e informazioni, ma ipotesi di spiegazione di sé e della realtà intera. Il vero dramma dell’uomo è quello di credere di bastare a se stesso, di accontentarsi delle facili spiegazioni, di ritenere troppo faticoso il proseguire il cammino, perché ci costringe a cambiare opinioni o abitudini. Ecco perché l’incontro è una visita: muoversi per andare a cercare e godere della scoperta. Il filiosofo ebreo-francese Emanuel Lévinas (1905-1995) propone Abramo come il modello etico dell’ospitalità (che per Lévinas non consiste nell’assunzione di un atteggiamento di buona educazione o di elemosina): «L’altro come lo straniero è l’ospite, verso il quale sono tenuto a esercitare il primo dovere etico: l’ospitalità. La sua condizione di apolide, di senza patria, che lo fa straniero in ogni Paese qualunque esso sia, universalizza l’esigenza dell’accoglienza».
A differenza dell’uomo greco che cerca all’infinito, il cristiano è colui che ha cercato ed ha trovato qualcuno che entra in casa e si predispone a sentire una parola di perdono, una parola mai udita (in- audita), inedita, che fa barcollare la fragile certezza della nostra ragione. Quando il padre della parabola del figlio ritrovato esplora lo spazio del suo orizzonte e da lontano scorge il figlio, si prepara a ricevere elementi ignoti, pericoli che potrebbero disorientarlo, imprevisti. Eppure egli si protende verso il figlio, aspettava una sua visita drammatica, ma repentinamente si mette nei panni di chi deve essere visitato. La visita dell’altro, dello straniero, non è un viaggio organizzato in cui tutto è già stato pensato. Oggi sembra sia impossibile pensare ad una dimensione di avventura al di fuori di contesti predefiniti e controllati, al di fuori di condizioni che negano la scoperta. Che tipo di incontri si possono fare su una nave da crociera dove tutti sono vestiti allo stesso modo, rispettosi della stessa etichetta, per i quali sono previsti gli stessi divertimenti e le stesse cerimonie mondane? Il piacere, in questo caso, non risiede nello sconosciuto, ma nel riconoscimento delle immagini stereotipate, viste e riviste mille volte dai depliants: il piacere del viaggio consiste nella ripetizione di un modello. Se invece analizzassimo le visite di Gesù ci renderemmo conto che pongono le basi per una cultura diversa dell’incontro: da quella a Matteo Levi, a quella rigenerante di Lazzaro a quella con la donna colta in flagrante adulterio. In esse noi assistiamo ad un imbarazzante capovolgimento, quasi come se il visitatore lasciasse entrare il padrone di casa e gli manifestasse, attraverso i suoi noti spazi, l’intimità di se stesso. Ogni visita è così uno svelamento, l’esplorazione di una geografia interiore, un profondo attraversamento delle proprie regioni dell’anima. La cultura dell’accoglienza come visita scava le condizioni per costruire le proprie ragioni di vita. La ragione di vita è un processo di accettazione della volontà di Dio, vissuta come propria, libera e coraggiosa scelta, che non deriva più dalla pianificazione altrui, ma dalla ricerca di una ragione del cuore, che legittimiamo come valore ed ideale. L’accoglienza sincera, dunque, ha bisogno di accettare la sfida del lasciarsi visitare dalla diversità. Imparando la grammatica antropologica dell’ascolto e dell’attesa. Per esempio siamo chiamati, di fronte alla proliferazione di culture diverse dalla nostra, a interrogare innanzitutto la qualità della nostra testimonianza cristiana, così che essa interroghi tali culture; come secondo esempio, di fronte alla presenza straniera siamo chiamati ad accettare come un dono e non come una condanna la possibilità di unire, pur senza confonderli, i nostri vissuti simbolici e le nostre categorie antropologiche e interpretative. Non possiamo non pensare alla permanente necessità di dialogo che ha caratterizzato la vita cristiana di Paolo, la sua indomita volontà di entrare in contatto con mondi ed esperienze e addirittura il fatto che egli stesso abbia rappresentato come persona, un pluriverso culturale ed etico, che forma come un modello per noi cristiani di questo tempo. Paolo di Tarso maestro di ogni uomo, anche non cristiano, ci riporta alla ricerca di territori in cui la salvezza non sia opera di opere, ma giunga come un dono a chi sa farsi educare alla libertà e sperimenti nella sua esistenza il rispetto della dignità di ogni uomo. I fondamentalismi, rischio e minaccia del nostro secolo, negano che ogni religione sia portatrice di un messaggio di pace e di un progetto di liberazione.
- Accogliere attraverso un progetto comune: rigenerare lo sguardo
Chiamiamo tutti, ora, a lavorare per il presente e il futuro della nostra gente e della nostra terra. Progettare, ovvero leggere dai volti dei bisogni concreti, interpretarli, pensare ad un raggio ampio di possibili risposte, verificare la qualità di quanto proposto. Progettare, ovvero raccogliere tutti quei volti che rappresentano le risorse umane, associative, culturali e materiali della comunità, chiamare alla corresponsabilità altri volti appassionati, assetati di giustizia e competenti, valorizzare i talenti di singoli e gruppi mettendoli al servizio di un unico fine. Progettare, ovvero evitare le formulazioni generiche, entrare nello specifico, tradurre il progetto in programma concreto, fatto non solo di date, ma soprattutto di persone concrete da incontrare e affascinare, di obiettivi chiari e verificabili. Prima di tutto: incontrare l’Altro e l’altro. Ma c’è una premessa al nostro progetto, ed è essenziale mettervi mano: incontrarli davvero questi volti. Non solo nelle pie intenzioni. Ma in strada, nelle case, nei luoghi di studio e di lavoro. Come sarebbe bello se ogni credente della nostra Chiesa fosseanimato da un’unica priorità assoluta: incrociare il suo percorso con il percorso dell’altro. Non a meri fini di proselitismo religioso o di assistenzialismo umanitario, ma per comunicare l’immensa gioia che l’incontro personale con Dio ha portato nella nostra vita. Rieduchiamoci all’ospitalità attraverso esercizi pratici. Incontrare, ovvero passeggiare nel quartiere e in città, fermarsi a guardare i volti, interrompere il proprio cammino per ascoltare, parlare… Incontrare, ovvero prendere a cuore il problema specifico dell’altro, anche e soprattutto i più ordinari, assaporare nella quotidianità la gioia di vivere non solo per se stessi, ma anche per l’altro… Incontrare, ovvero fare il primo passo nella direzione dell’altro, con un fine concreto: stabilire non solo un contatto, ma fondare una relazione, una relazione che ha tempi, spazi, parole, gesti… Rinnovare lo sguardo per rigenerare l’altro, questo è il presupposto dell’accoglienza. La vera intelligenza, oggi, sta nell’imparare un nuovo – e vero – modo di vedere e guardare gli altri. Le Scritture ci aiutano, quando ci propongono quel guardare dentro/amando (em-blepein) che rende l’altro rigenerato, reinventato, ritrovato. Se il nostro sguardo comunica amore, rimanderà all’amore originario di Dio Padre. Ma l’osservatore/amante è anche colui che non piega il prossimo ai suoi desideri, non ne mina la libertà, piuttosto è capace di assumere l’imprevedibilità dei moti del suo cuore. Il nostro sguardo sia liberante e non opprimente, piuttosto aiuti l’altro a riscoprire la sua stessa capacità di guardare al mondo e ai fratelli con gioia e responsabilità. Rinnovare lo sguardo, ovvero smetterla di dire e pensare male, abbandonare ogni pregiudizio, riconoscere qualsiasi uomo come creatura prediletta del Padre… Rinnovare lo sguardo, ovvero puntare dritto al cuore dell’uomo, là dove c’è purezza, natura buona, bellezza… Rinnovare lo sguardo, ovvero coltivare un desiderio: che l’altro sappia andare in mare aperto con le proprie forze, certo però che una comunità gli è sempre vicina…
Mi piace ricordare la citazione di un testo che rimando al vostro approfondimento personale e che mi ha aiutato nella redazione di queste mie riflessioni: C. Di Sante, Lo straniero nella Bibbia. Ospitalità e dono, San Paolo, Cinisello Balsamo 2012. L’autore così sintetizza i tratti dell’ “io ospitale”: “Tenere la porta della propria camera aperta”; “dare il benvenuto”; “accorgersi di cui l’altro soffre ed ha bisogno”; “fare spazio all’altro”; “donare cio’ che si ha”. Siano queste quattro vie, attualizzate e declinate nei nostri contesti familiari e parrocchiali, il percorso esodale da noi stessi all’altro.
- Suggestioni pastorali
“Gli uomini temono il pensiero più di qualsiasi cosa al mondo, più della rovina, più della morte stessa. Il pensiero è rivoluzionario e terribile. Il pensiero non guarda ai privilegi, alle istituzioni stabilite e alle abitudini confortevoli. Il pensiero è senza legge, indipendente dall’autorità, non curante dell’approvata saggezza dell’età. Il pensiero può guardare nel fondo dell’abisso e non avere timore. Il pensiero è grande, acuto libero, la luce del mondo, e la più grande gloria dell’uomo. Se il pensiero non è bene di molti, ma soltanto privilegio di pochi, lo dobbiamo alla paura. È la paura che limita gli uomini, paura che le loro amate credenze si rivelino delle illusioni, paura che le istituzioni con cui vivono si dimostrano dannose, paura di dimostrarsi essi stessi meno degni di rispetto di quanto avessero supposto di essere” (Bertrand Russell, Principi di riforma sociale, 1996)
a) La forza della ragione e la forza del Vangelo: antidoti contro la paura
Da tutto quanto detto emergono a mio avviso alcuni suggestioni pastorali, che esprimo brevemente. Le prime suggestioni riguardano lo stile della comunità cristiana di fronte all’ospite che viene a farci visita. Mantenendo sempre ferma la stella polare delle relazioni e dell’incontro con l’altro, ci imbattiamo in un problema concretissimo e drammatico: la paura. Il lavoro più grande che le nostre comunità devono fare è creare degli antidoti alla paure dell’ospite, del visitatore, dello straniero. Questi antidoti sono nel Vangelo. Ma sono anche nella ragione. Non c’è alternativa all’incontro e alle relazioni. Non possiamo scappare da questo fenomeno grande delle migrazioni. Razionalmente, oltre che evangelicamente, siamo tenuti, obbligati a sfidarci in una relazione nuova. Quale sarebbe l’alternativa? La violenza? La chiusura? I ghetti? Non solo evangelicamente, ma anche razionalmente queste vie sono ben peggiori di quelle che possono nascere dal dialogo e dall’incontro faticoso. Occorre lavorare sulle paure e provare a smontarle con buone ragioni. Tante opinioni grossolane circolano sul “lavoro” che queste persone verrebbero a toglierci, sui “privilegi” che lo Stato gli darebbe, sul pericolo terroristico, sulla sottomissione religiosa… Queste opinioni fanno presa sulle persone spaventate, ma noi culturalmente dobbiamo osare una verità più complessa per ridimensionare paure che vanno oltre il lecito. Io vedo questo lavoro sulle “paure” delle nostre comunità cristiane quasi propedeutico a ogni altra iniziativa.
In verità il lavoro dovrebbe poter far forza sulla dinamica positiva dell’accoglienza e questa a partire dalle relazioni interne alle comunità stesse, “un regno diviso in se stesso…”. Questo dovrebbe significare una riqualificazione all’interno della comunità che dovrebbe partire dall’accoglienza dell’altro come dono della diversità: diversi carismi, diverse vie di santificazione, diversi itinerari per la fede. Solo una comunità che si lascia cogliere come un coro di voci pronte alla sinfonia e non una granitica esperienza dove esiste una sola porta per accedere alla sala, può rendere credibile una Chiesa che si propone come luogo di integrazione e di pluralità, tempio dello Spirito perché casa delle diversità. La scelta è l’inclusione -come suggerisce papa Francesco- piuttosto che far vivere l’esclusione.
b) Non solo piatti di pasta ma vera integrazione: lo snodo delle parrocchie, dei gruppi e le reti del buon senso
Un profondo lavoro culturale sulle paure della nostra gente può poi aprire la strada ad una operatività larga, solida e creativa. Credo che l’assistenza materiale di cui si fanno carico in modo a volte contraddittorio lo Stato, e in modo generoso gli enti caritatevoli, siano altamente insufficienti. La vera sfida è un’integrazione che passa in primis attraverso gli incontri e le relazioni personali e senza pregiudizi, e in seconda analisi attraverso vere e proprie alleanze che comprendano parrocchie, scuole, associazioni, istituzioni. Il fenomeno è complesso e articolato, nessuno può farsene carico da solo. Una forma di narcisismo, d’altra parte, è proprio pensare di affrontare da soli questioni che giganteggiano sulle nostre capacità. Una forma di maturità umana e cristiana, invece, è lavorare per alleanze e reti in cui ciascuno faccia la propria parte.
Mi riferisco in particolare a certe forme di presenza che non mostrano il volto della comunità, quanto piuttosto la singola persona che è individuata per la sua indubbia disponibilità ma che non trasmette la presenza di una famiglia credente alle spalle, in questo la necessità di far crescere gli operatori pastorali -presbiteri, diaconi, religiosi, religiose e laici- in quella dimensione del sentirsi come “sacramento” della comunità. In questo senso sarebbe sempre più significativo che gli operatori potessero mostrarsi insieme in una integrazione di vocazioni che di per sé sarebbe già segno di uno stile nuovo di essere chiesa.
Un punto di partenza potrebbe essere promuovere l’integrazione delle nuove famiglie alla comunità, ponendo una specie di osservatorio delle nuove presenze in quartiere così da evidenziare i nuclei ospitati per poterli poi visitare, offrire loro un riferimento parrocchiale. Dobbiamo porci nella dimensione di dover essere noi a cercare i fratelli, uscendo dalla dinamica dell’eterna attesa in cui si è spento lo spirito missionario che altro non è che l’esperienza viva di Dio che ti viene a cercare attraverso il volto dell’altro.
- Le sfide dell’educazione per la Famiglia Vincenziana
EDUCAZIONE ALLA COMPASSIONE
È un vero e proprio itinerario. Non è l’educazione alla commozione. La commozione non è condizione necessaria e sufficiente per la compassione. Educarsi alla compassione è un vero e proprio itinerario. Prima tappa: educarsi a vedere il bene che è nell’altro poiché figlio di Dio; educarsi a discernere la verità nella storia di vita di una persona, partendo dalla propria vita; educarsi a sentire fisicamente ed emotivamente il problema dell’altro come problema proprio; educarsi a uno stile di vito in cui la solidarietà non è sacrificio bensì beneficio, o meglio è beneficio altissimo attraverso il sacrificio.
EDUCAZIONE ALLA CURIOSITA’
Senza curiosità noi non possiamo avvicinarci all’altro. Se non comprendiamo che l’altro è una miniera di conoscenze ed esperienze, avremo sempre un approccio chiuso. L’altro può arricchire la nostra vita, ma non a chiacchiere. Idee e filosofie di vita. Tradizioni. Cibo. Rapporto con i soldi e con i beni. Tutto può essere messo in discussione della nostra vita nell’incontro con un’altra cultura. L’integrazione parte dalla curiosità.
EDUCAZIONE ALLA LIBERTA’
Oggi va di moda un binomio. Libertà uguale sicurezza. È giusto, gli attentati ci fanno paura e noi vogliamo una sicurezza tale che ci consenta di sentire un concerto senza perdere la vita. Ma, dobbiamo dirlo, la libertà non è blindata, la libertà si rischia, la libertà si vive nelle zone di confine. Nelle sicurezze noi maturiamo una forma di libertà particolare, che possiamo definire occidentale. Non dimentichiamo che Cristo è stato libero sulla croce, non quando Pietro ha sciorinato la spada per difenderlo. Educhiamoci alla libertà di osare il rapporto con il diverso.
TUTTO PARTE SEMPRE DALLA FAMIGLIA
I pregiudizi nascono da papà e mamma, dai nonni. Non partono dai piccoli. Le esperienze migliori di integrazione nascono dai piccoli, dalla scuola. Noi dobbiamo lavorare a traino dei più piccoli. Se un nostro figlio sta in classe senza problemi con un ragazzo straniero, noi grandi dobbiamo completare il lavoro stando senza problemi con il papà e con la mamma. Il lavoro dell’integrazione non nasce da grandi megaprogetti che spesso sprecano soldi pubblici, ma dal piccolo, dal quotidiano.
UNA CHIESA VERA E NON INGENUA
Nel grande lavoro dell’integrazione emerge l’importanza della Chiesa come mistero e come comunità. Come mistero, perché solo come mistero possiamo aprirci al mistero di una vita che non conosciamo. Come comunità, perché solo come comunità possiamo applicare quel discernimento sulla verità della persona e della sua storia. Spesso lo straniero, così come il debole, il povero, è una miscela di rabbia, verità, desiderio, anche scaltrezza. Solo una comunità può aiutare nella verità e senza scadere nell’ingenuità e nel buonismo fine a se stesso.
[1] Z. Bauman, Le sfide dell’etica, Milano 1996, 244-247
[2] Dal discorso del Card. Crescenzio Sepe per l’apertura di Port’Alba, 3 ottobre 2011
Documento PDF: La Spiritualità Vincenziana e la sua sfida profetica
Tags: Beniamino De Palma, Conferenza, Famvin400, Simposio